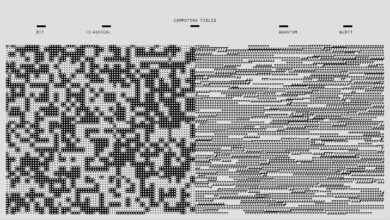Dimensione del testo: A Reducir tamaño de fuente. A Restablecer tamaño de fuente A Aumentar tamaño de fuente.
Dietro ogni aumento dei prezzi si nasconde una catena di decisioni, eventi e interessi che spesso superano i confini nazionali.
Oggi Punti Cardinali esplora il lato geopolitico dell’inflazione: non solo cause e colpe, ma anche chi ci guadagna mentre le famiglie fanno i conti.
Inflazione, la narrazione ufficiale: tra BCE, tassi e consumo
Quando si parla di inflazione, la versione ufficiale ci porta subito ai movimenti della Banca Centrale Europea, al rialzo dei tassi per contenere la domanda e alla necessità di “raffreddare” l’economia per riportare i prezzi sotto controllo. In questa narrazione, l’inflazione è spesso vista come un problema interno, da gestire con strumenti tecnici, misurabili. Ma sempre più spesso, questa rappresentazione risulta parziale.
Le vere cause globali: quando la politica estera incide sulla spesa interna
La verità è che l’inflazione del nostro tempo è figlia di una geopolitica agitata. Le rotte commerciali si accorciano o si allungano a seconda dei conflitti. Le guerre – dall’Ucraina al Mar Rosso – incidono sulle materie prime, sui trasporti, sulle assicurazioni marittime. Un container che impiega 20 giorni in più per arrivare, ha un costo. E quel costo si riflette sul banco del supermercato.
Allo stesso tempo, la corsa globale a risorse come gas, microchip o terre rare genera meccanismi di accaparramento, tensioni nei mercati e dinamiche speculative. Il prezzo del pane, del carburante, del cellulare nuovo è sempre più sensibile a ciò che accade tra Washington e Pechino, a un tweet da Teheran, a una nave ferma nello Stretto di Hormuz.
I nuovi vincitori: chi prospera nell’instabilità?
C’è chi l’inflazione la subisce, e chi la cavalca.
I primi vincitori sono gli Stati esportatori di energia, come la Russia, il Qatar, l’Arabia Saudita e – in modo meno visibile ma non irrilevante – anche gli Stati Uniti. L’instabilità altrui si trasforma per loro in margini di profitto.
Subito dopo ci sono i big della logistica globale: gruppi come Maersk, MSC, e le principali compagnie cargo aeree, che controllano flussi, rotte, e in un certo senso anche il “tempo” dei mercati. In un mondo più incerto, chi garantisce continuità ha più potere.
Poi ci sono gli attori finanziari: fondi speculativi, hedge fund, investitori istituzionali che giocano sui futures delle materie prime, che scommettono sulla scarsità, che muovono capitali dove c’è inflazione aspettandosi rendimenti. E infine, le multinazionali con forte potere di prezzo: nel settore alimentare, tecnologico, farmaceutico. Aziende capaci di aumentare i listini più velocemente dei costi.
E l’Italia? La posizione di un Paese esposto ma non ininfluente
L’Italia vive un doppio vincolo strutturale: da una parte la dipendenza energetica (abbiamo fatto passi avanti, ma siamo ancora lontani da un’autonomia strategica); dall’altra un debito pubblico elevato che ci rende sensibili a ogni movimento dei tassi e dei mercati finanziari.
Tuttavia, abbiamo alcune carte da giocarci. Il Made in Italy ha ancora appeal globale, specie nei settori agroalimentare e moda, ma questo vantaggio rischia di erodersi se il costo del lavoro resta alto e le imprese non investono in efficienza e filiere corte. Inoltre, l’appartenenza all’UE ci garantisce una rete di protezione (finanziaria e diplomatica) che va valorizzata con più iniziativa e meno attendismo.
Leggere l’inflazione come un indicatore geopolitico
Pensare di risolvere l’inflazione solo con leve monetarie è come curare la febbre ignorando l’infezione. I prezzi salgono perché il mondo è instabile, perché le catene del valore sono fragili, perché alcuni attori globali hanno interesse a mantenere alta la tensione.
L’inflazione è uno specchio di un ordine globale in transizione. Serve una nuova alfabetizzazione economica dei cittadini, una responsabilità politica più strategica e una capacità collettiva di leggere i segnali deboli.
Perché non è solo questione di spendere meno: è questione di capire di più.