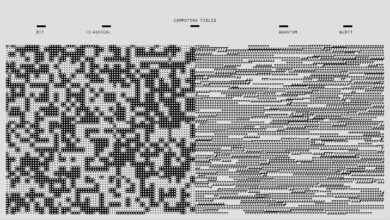Dimensione del testo: A Reducir tamaño de fuente. A Restablecer tamaño de fuente A Aumentar tamaño de fuente.
Siamo entrati nell’era della fatica collettiva. È una sensazione diffusa, quasi palpabile, che attraversa le persone, le imprese, le istituzioni. Le parole si svuotano, i progetti si accorciano, la fiducia cala. La narrazione dominante è quella della “ripartenza”, della “resilienza”, del “fare di più con meno”. Ma sotto la superficie si avverte un’onda diversa: una stanchezza esistenziale e sistemica, una sorta di esaurimento energetico dell’Occidente.
Un Occidente affaticato
Secondo il World Happiness Report 2024, la percezione del benessere nei Paesi occidentali è in calo, soprattutto tra i giovani: Stati Uniti, Francia, Germania e Italia hanno registrato un crollo nei livelli di soddisfazione tra i 16 e i 25 anni. Anche il Gallup Global Emotions Report segnala che i livelli di stress, tristezza e ansia sono ai massimi storici, superando di gran lunga quelli del periodo pandemico. Non è solo questione di salute mentale individuale: è un problema sistemico. Le democrazie liberali sembrano esaurite nella loro spinta propulsiva. Il think tank Demos parla di “demoralizzazione diffusa delle società occidentali”, dovuta alla perdita di narrazioni mobilitanti, al crollo del patto intergenerazionale e alla sfiducia nelle istituzioni.
Studi e segnali: il sintomo non mente
Uno studio congiunto delle Università di Harvard e della LSE pubblicato su The Lancet Psychiatry nel 2023 ha evidenziato una correlazione crescente tra declino della partecipazione civica, burnout lavorativo e disturbi ansioso-depressivi. Il fenomeno è particolarmente acuto tra i lavoratori del settore terziario e le nuove generazioni, che vivono in un paradosso: più titoli, meno stabilità. Più connessioni, meno comunità. Più libertà apparente, meno direzione. Nelle aziende, l’esplosione dei programmi di “wellbeing” convive con il moltiplicarsi di dimissioni silenziose, demotivazione e perdita di engagement. L’indagine McKinsey Health Institute 2024 mostra che il 59% dei dipendenti in Europa non si sente supportato emotivamente dal proprio ambiente di lavoro, e il 40% vive una “stanchezza morale”. Anche nello sport il corpo sociale parla. Atleti di punta come Simone Biles o Dominic Thiem hanno raccontato pubblicamente la loro lotta con la pressione mentale, rivendicando il diritto al limite, alla cura, alla verità. Questi segnali non sono deviazioni: sono diagnosi.
Questa stanchezza diffusa si esprime anche in pratiche quotidiane che rivelano un disagio più profondo. Una delle più emblematiche è il cosiddetto “revenge bedtime procrastination”, ovvero la tendenza, sempre più comune, a sacrificare il sonno per ritagliarsi tempo personale nelle ore notturne, dopo giornate vissute come alienanti o prive di controllo. È un atto di ribellione silenziosa, spesso inconsapevole, contro una vita percepita come “rubata” da lavoro, doveri e pressioni esterne. A questa si affiancano comportamenti come il doomscrolling (consumo compulsivo di notizie negative), il toxic productivity loop (sentirsi in colpa quando si riposa), o la dipendenza da stimoli continui (social, audio, notifiche) per evitare il silenzio interiore. Tutti segnali di un sistema che ha spinto l’uomo a perdere il contatto con i propri ritmi naturali e con il significato del tempo vissuto.
La crisi non è solo economica, è di significato
Il vero deficit è quello di senso. Le organizzazioni, pubbliche e private, sono spesso impegnate a correre più che a capire dove stanno andando. L’obiettivo si è ridotto al breve termine, la misura è diventata fine a sé stessa, la crescita si è separata dal bene comune. Il sociologo tedesco Hartmut Rosa, nel suo libro “Risonanza”, parla di una “crisi di relazione col mondo”: accelerazione senza connessione, efficienza senza senso. Quando tutto è misurato, ma nulla è significativo, l’anima collettiva si ammala. Non a caso cresce l’interesse per modelli organizzativi che integrano coscienza, sostenibilità e spiritualità pratica. Perché senza radici, l’albero cade.
Ritrovare l’asse: spiritualità come leva strategica
La vera sfida dell’Occidente non è (solo) tecnologica, ma spirituale. Non in senso religioso istituzionale, ma nel risveglio di una coscienza integrata: visione, valori, verità. Le imprese che avranno successo saranno quelle capaci di incarnare un significato, non solo un modello di business. Quelle che faranno della leadership una responsabilità, non un privilegio. È tempo di organizzazioni che curano, non che consumano. Di economie che generano benessere vero, non solo profitto. Di società che riscoprono la parola “vocazione” non come retorica, ma come rotta. Serve una nuova energia: non adrenalinica, ma profonda. Non fondata sulla prestazione, ma sulla presenza. Non sul fare, ma sull’essere.
Solo così, forse, usciremo dall’epoca della stanchezza. E torneremo a costruire futuro.